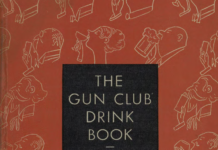Bartender, campionessa, imprenditrice, personaggio Tv, mentore, speaker, designer: Kate Gerwin risponde a ciascuna di queste definizioni, tenendole tutte collegate con il filo della sua passione per il bar e per l’ospitalità. Oggi è titolare di Happy Accidents, ad Albuquerque, New Mexico (Usa); lontana dai riflettori ma costantemente al centro di attività di formazione, eventi e incontri ovunque nel mondo, contribuendo con esperienza e opinione allo sviluppo della comunità bartender mondiale. È lei l’ospite della nuova puntata di Off the record.
Ci sentiamo mentre sei nel mezzo di un tour europeo, tra Barcellona, Atene e Milano. Essere una traveltender è fondamentale al giorno d’oggi?
Non direi. Viaggiare è utile per il marketing e le pr e di certo aiuta a ottenere una visibilità che può tradursi in grandi opportunità. Per me che faccio parte di un mercato piccolo è un vantaggio enorme, perché mi permette di assorbire da altre culture, comprendere i trend e diversificare il programma del bar. Ogni volta che torno porto qualcosa di nuovo da implementare, e così il bar cresce. Non credo che viaggiare così tanto sia altrettanto cruciale per bar di New York o Londra. E so di essere privilegiata perché ho uno staff straordinario che mi permette di stare fuori a lungo: quando torno a casa sono praticamente inutile nel mio bar, perché una macchina perfetta grazie a loro.
«Se sei un bar di quartiere, paghi le bollette grazie ai tuoi clienti abituali. E loro se ne fregano dei trofei»
Viaggiare può aiutare nel costruire una rete che porti a premi e riconoscimenti?
Certo, ma non credo i premi siano indispensabili; di sicuro garantiscono esposizione mediatica e piacciono, ma a un certo punto bisogna chiedersi: chi paga le bollette? Se sei un bar di quartiere, sono i tuoi clienti abituali e loro se ne fregano delle liste: vogliono solo stare bene. Apprezzano che tu viaggi per portar loro nuove esperienze culturali, non certo per i trofei.
Albuquerque, dove sei di base, è piuttosto lontana dai riflettori: è un vantaggio o un ostacolo?
È più un vantaggio che una penalità. L’unico lato negativo, che odio davvero, è che in mercati piccoli la gelosia è più profonda verso quei pochi bar che ce la fanno. Questa mentalità può essere frustrante, ma tutto il resto gioca a nostro favore: ogni cosa che impari fuori e riporti a casa ti dà un vantaggio in termini di opinioni, tecnica e cultura. C’è anche da combattere una buona dose di incomprensione.
Ovvero?
Il lavoro che facciamo viene spesso sottovalutato e ridotto a una sorta di vita da rockstar, pressoché sempre in viaggio, come me, Iain McPherson, Danil Nevski. Dietro, però, c’è una montagna di lavoro, di assenze da casa e famiglia, e un grande investimento di energie, anche solo per mantenere una presenza “social”, cose che magari in contesti meno cosmopoliti può non essere sempre capita.
«A noi bartender servono le stesse nozioni di uno chef e in più dobbiamo gestire il faccia a faccia con il cliente.
Eppure siamo ancora visti come quelli che vogliono far tardi e divertirsi»
Hai una solida e positiva esperienza in Tv, con una bellissima partecipazione a Drink Masters (show di Netflix, ndr): credi ci sia abbastanza consapevolezza tra i professionisti del settore, perché il bar abbia davvero appeal come è stato per gli chef?
Per nulla, ed è uno dei motivi per cui ho accettato di partecipare al programma. Per essere bartender di alto livello sono necessarie una conoscenza e una competenza enormi, ma spesso siamo ancora visti come quelli che vogliono solo far tardi e divertirsi. In realtà dobbiamo avere le stesse nozioni di uno chef, anzi, dobbiamo conoscere una quantità di brand e prodotti sterminata, reagire a richieste di cocktail fuori carta in pochi secondi, spiegare menu, e allo stesso tempo gestire l’aspetto sociale, faccia a faccia con il cliente, che in cucina manca. Il programma Tv ha avuto un buon impatto, ma vorrei che la passione che mettiamo in questo lavoro fosse trasmessa meglio al consumatore finale: c’è tantissimo da raccontare, che ancora rimane sommerso.
La community fa abbastanza perché il grande pubblico reagisca nel modo giusto?
Facciamo molto, ma è difficile per il pubblico comprendere tutto se siamo in pochi a impegnarci davvero. C’è ancora tanto lavoro di divulgazione da fare, anche sui social, e non è facile. Mi piacerebbe che ci fosse un Anthony Bourdain del bartending, qualcuno che racconti il lato umano e passionale del nostro mestiere.
«Tutti rincorrono la popolarità, troppo spesso a scapito dell’ospitalità. Io valuto un bar osservando se lo staff è felice»
La community del bar è sana?
Assolutamente no. Ma ci stiamo provando. Stiamo iniziando a capire cosa va sistemato: le ore di lavoro da inquadrare, il consumo eccessivo di alcool e droghe, i ritmi insostenibili. La competizione non è sempre sana: tutti rincorrono la popolarità, troppo spesso a scapito dell’ospitalità.
I 50 Best rimangono un argomento trainante.
Ciascuno deve capire vuole davvero dall’industria e quanto è disposto a impegnarsi per ottenerlo. Alcuni bar “giocano al gioco” fino in fondo, e se il mercato lo richiede, funziona. Noi ad Albuquerque siamo entrati nei 50 Best America, ma non abbiamo visto un grande aumento di clienti dopo essere stati inclusi. Quando però siamo finiti sul giornale locale, sì, l’impatto si è sentito. Ci sono motivi validi per “giocare al gioco”, ma bisogna capire quanto si è in grado di sostenerlo: tra guest shift, bar show, premi… è estenuante.

Cosa non sopporti del settore oggi?
L’ipocrisia. Tutti vanno ai pop up degli altri, poi ne parlano male dopo aver assaggiato i drink. È pieno di giudizio gratuito. Il gusto è soggettivo, è ingiusto dire che qualcosa “fa schifo” a prescindere. Io valuto un bar osservando lo staff: se è felice, se interagisce con i clienti, se contribuisce alla comunità. Soprattutto nei luoghi a carattere più locale, se non vai in chiesa, vai al bar. E il bar dovrebbe essere un luogo di comunità.
Un esempio?
Tres Monos a Buenos Aires, in Argentina: hanno creato una scuola di formazione per persone svantaggiate. Non lo fanno per marketing, ma per spirito di comunità. Ecco, quelli sono i migliori bar del mondo per me: quelli da cui voglio imparare.
In una recente intervista racconti che un paio d’anni fa dicevi che le donne dovevano avere una “corazza”, poi hai cambiato idea e hai detto che sono gli uomini a dover cambiare. È successo?
Non ancora, ma qualcosa si muove. Sono sempre riuscita a scrollarmi tutto di dosso, e ne sono orgogliosa, ma non è così per tutte. In una chat Whatsapp globale di donne bartender, recentemente abbiamo parlato di un articolo sui 50 Best: il titolo era “Abbiamo parlato con i migliori bartender del mondo” e c’erano solo uomini. In una stanza piena di donne straordinarie, nessuna intervistata. Oppure guest shift di gruppo con una sola donna, messa in un angolo. L’industria deve capire che così perde talenti incredibili, e a rimetterci è tutto il settore.
«troppo spesso si includono donne perché “bisogna”, non perché si riconosce il talento»
Essere imprenditrice comporta difficoltà aggiuntive rispetto all’essere bartender?
“Oh, tu sei la proprietaria del bar?!”, lo sento spesso. Le imprenditrici donne non hanno ancora lo stesso peso, ma vedo segni di cambiamento. Tuttavia, c’è ancora troppo tokenism: si includono donne perché “bisogna”, non perché si riconosce il talento.
C’è qualcosa che avresti voluto sapere prima di diventare imprenditrice?
Sì, avrei voluto conoscere meglio l’aspetto finanziario e gestionale. Gestire un bar non è divertente come si pensa: è burocrazia, organizzazione, responsabilità. Non basta saper fare ottimi drink.
Ti concentri molto sul benessere dello staff: come lo promuovi?
Attraverso una comunicazione genuina. Voglio sapere come stanno, davvero. Devono sentirsi liberi di esprimersi, anche nel conflitto. E devono potersi permettere di dire a un ospite che non è gradito: l’ospite non ha sempre ragione. Capisco il servizio di altissimo profilo, ma la vera ospitalità è altra cosa. Voglio che il mio staff si senta libero di parlare apertamente.
Con oltre vent’anni di esperienza, cosa hai visto davvero cambiare nel settore? E di cosa ti senti più responsabile?
Ho cercato di portare più attenzione sulla salute mentale. Oggi più bar, brand e professionisti iniziano a preoccuparsi del benessere reciproco. Siamo ancora lontani da una situazione ottimale, ma stiamo comprendendo quanto il nostro lavoro impatti sugli altri e su noi stessi. E soprattutto, stiamo imparando a vedere le persone per quello che sono — senza bias di genere.
 Sei anche una madre, e ti batti per dimostrare che è possibile mantenere un equilibrio familiare lavorando al bar.
Sei anche una madre, e ti batti per dimostrare che è possibile mantenere un equilibrio familiare lavorando al bar.
È ancora difficile, perché è mal compreso da entrambi lati del bancone. Per molti imprenditori è un tabù, la maternità è vista come una sorta di ostacolo insormontabile: pochissime donne incinte verrebbero assunte, e il post-partum è sempre complicato burocraticamente, cosa che si aggiunge alle difficoltà intrinseche della cosa. C’è ancora molta strada da fare.
Sei stata la pima donna vincere una competizione globale (Bols Around the World nel 2014). Le competizioni servono davvero al percorso di un bartender?
Sì, possono essere utili per la crescita personale e la visibilità. Mi hanno aiutata molto ed essere stata la prima a vincere una competizione di quel tenore è servito anche ad altre donne per capire che è possibile per tutte. Ma ci sono anche lati negativi: l’impatto emotivo può essere forte, perché i giudizi sono inevitabilmente soggettivi, non so mai d’accordissimo quando leggo di giudizi imparziali. Non è impossibile che una performance o una ricetta di gran qualità poi non siano quelle vincenti, perché molto dipende dall’esperienza, dai ricordi, dalle idee dei giudici. Come dice Al Pacino in un suo film celebre, Any given Sunday (Ogni maledetta domenica, ndr), qualcuno vince o perde. Quello che davvero conta è come vinci o perdi.
«Versate sbagliate, overpour, uso scorretto del jigger: stiamo perdendo di vista la tecnica. E diamo poca attenzione all'ergonomia del bar»
In un tuo recente articolo hai detto che i bartender del mondo stanno perdendo sempre più di vista la tecnica. Lo credi ancora?
Assolutamente sì. Ho avuto la fortuna di visitare i migliori bar del mondo, ma anche lì ho visto errori basici: versate sbagliate, overpour, uso scorretto del jigger, shakerate corte, poca concentrazione. Si parla tanto di salute mentale, ma poco di ergonomia: bartender che impugnano strumenti in modo esteticamente attraente ma si distruggono i polsi, o bar progettati male che ti costringono a piegare la schiena in continuazione. Invece di versare con il mignolo alzato dovremmo concentrarci più su cosa davvero è fondamentale.
“Siate autentici” è uno dei tuoi mantra: è davvero così importante?
Sì, ma non è tutto. Non tutti vanno bene per tutti, e va bene così. Essere se stessi non significa essere diversi, ma dimostrare che non esiste una formula unica per il successo. Più persone lo capiscono questo, più l’industria cresce, ma non va sottovalutato tutto il resto: chiunque può essere sé stesso in questa industria, ma è un mestiere che richiede una quantità di energia enorme. Sempre.