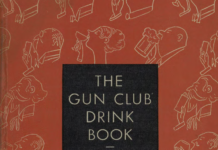Sul finire di 2025, L’Antiquario di Napoli celebrerà il decimo anniversario della sua apertura. È un compleanno simbolico, che testimonia il lavoro infaticabile e lungimirante di un bar che ha fatto scuola, in città di certo ma ben oltre i confini anche nazionali, ricercando l’eccellenza dell’ospitalità classica sia nelle ricette che nelle maniere.
Alex Frezza de L’Antiquario è co-fondatore e alfiere, divenuto bandiera di un approccio al bar che va sparendo eppure dimostra di avere ancora uno spazio prezioso ovunque nel mondo: quello delle giacche bianche, del coraggio di dire no (si servono solo cocktail e champagne), della continua osservazione di un mercato che cambia rapidissimo e propone sfide continue, per rimanere fedeli a se stessi e contemporaneamente rimanere attuali. È lui l’ospite della nuova puntata di Off the record.
Cocktail e champagne a L’Antiquario, in un momento storico in cui si dice sempre più spesso che si beve meno rispetto al passato.
Non credo sia il bere alcol il problema, sono piuttosto i luoghi dove poter avere un bicchiere in mano. Abbiamo troppi locali al chiuso, dove è necessario sedersi, nessuno invece che vuole fare volume e permettere agli ospiti di poter socializzare come si faceva una volta.
Vorresti più bar high volume e meno sperimentazione?
Anche gli high volume possono fare sperimentazione, magari snaturandosi in minima parte, perché i tempi cambiano. Freni e Frizioni a Roma o Kadavè in provincia di Napoli sono esempi di operazioni imprenditoriali che creano un flusso. Torino al contrario aveva porticati e piazze bellissime e con enormi potenzialità, ma ha perso un po' il filo.
«Se dovessi aprire adesso farei quattro vetrine e un discreto spazio all'esterno»
Commercialmente avrebbe senso aprire un bar come L'Antiquario oggi?
Se dovessi aprire adesso farei quattro vetrine e un discreto spazio all'esterno. Non so quanto abbia senso aprire un bar a porta chiusa, oggi, ma è anche vero che tutto cambia in base al luogo e decine di dinamiche a sé stanti. Cose specifiche accadono in posti specifici, all'Antiquario ne accadono alcune perché altre non possono accadere, semplicemente.
Ovvero?
Gli ospiti arrivano e spesso non hanno la più pallida idea di cosa succede dietro la tenda all'ingresso. Una volta dentro si rendono conto che si tratta di un bar vero, come dovrebbe essere inteso, dove si può parlare o si può solo guardarsi attorno. Entrano in ballo regole non scritte che in una piazza non avrebbero senso di esistere, a partire dal modo in cui si può (o non si può) interagire con altri ospiti.
Dieci anni sono un bel traguardo. C’è qualche riflessione che ti viene da fare, guardando indietro?
I tempi sono cambiati, ho visto più cose che non mi sono piaciute. Comincia finalmente ad affiorare un'idea chiara di chi veramente ama il bar e chi lo sfrutta come strumento per ottenere un ritorno. Quando le due cose si confondono si creano i mostri.
«Il flair? chi pensa ancora che lanciare bottiglie sia un valore aggiunto per il bar, non sa in che anno viviamo»
Per esempio?
I flair bartender che si domandano perché non ci sono più sponsor che li sostengano: sono dinosauri che hanno solo approfittato del bar. Chi è riuscito a trasmutarsi in altro come Marco Canova, Francesco Leoni, Bruno Vanzan, ha preso una strada che tutto è tranne che flair; chi invece rimane a lanciare bottiglie pensando sia un valore aggiunto per il bar, non ha capito in che anno viviamo e si lamenta se non è considerato in competizioni che presuppongono una conoscenza di cosa significhi lavorare, davvero, al bar.
Sembra quasi si sia perso il senso vero di cosa sia, vivere un bar dalla vostra parte del bancone.
Oggi ci sono bar che investono la stessa cifra per agenzia stampa e lavori di ristrutturazione, e non aveva senso già solo cinque anni fa. Ci abbiamo provato anche noi perché volevamo proiettare L’Antiquario in fasce che non riuscivamo a raggiungere organicamente, e ha funzionato fino a un certo punto, finché peraltro ci siamo resi conto che non potevamo permetterci un investimento del genere. I giochi sono cambiati così tanto che bisogna farsi delle domande: entrare in certe liste serve perché non è facile emergere, ma è un controsenso.
In che modo?
Una volta si apriva il bar, si lottava per diventare influenti e poi si entrava in determinate classifiche. Oggi il processo è inverso, esistono scorciatoie per cui posso essere in classifica prima di essere influente. Il meccanismo lo permette, ma i bar devono essere sempre bar e ormai non è più così: ho fatto guest in cui dopo dieci minuti di lavoro mi hanno letteralmente sequestrato per interrogarmi su come avessi fatto a entrare nei 50Best. Come se fosse davvero quello il grosso scoglio da superare.
Perché, qual è?
Il problema non è tanto entrare in classifica, quanto piuttosto sostenere le aspettative che poi si creano dopo, e lì non ci sono agenzie stampa o influencer che tengano, ci sei tu con ospiti che magari il giorno prima erano al Connaught. Ci sono tanti esempi di bar che hanno scalato le vette in fretta e poi sono scomparsi.
«Le cocktail week sono belle, ma quanto incidono sul mercato?»
C’è un giro d’affari che inquina l’integrità del bar?
Di certo, a differenza del settore dei ristoranti, al bar i marchi girano molto di più e quindi più soldi arrivano da là. Di conseguenza ci gravitano personalità che non amano il bar, ma colgono l'occasione per arricchirsi o sfruttarlo: bartender che non trovano soddisfazione al bar, ma si dedicano ai social o alla pubblicità, oppure organizzatori di eventi in cui non conta il contenuto, ma la visibilità. Per dirne una, tutte le cocktail week sono belle, ma quanto incidono sul mercato? Quanto sono sentite dalla comunità, e quanto invece sono strumenti di persone che non fanno parte del settore e lo sfruttano? Io capisco il mercato abbia spazio un po’ per tutto, ma troppo spesso si pensa sia facile sfruttare la community e lucrarci.
Il mercato così aperto cosa comporta?
Una scarsa professionalità. Se un ex impiegato di moda apre un bar e non un ristorante stellato, c'è un motivo. È interessante combattere con nuove idee, ma andrebbe riconosciuto quando c'è da stare zitti, se queste idee non ci sono. E invece si vedono bar che pensano di fallire se non spingono un contenuto social, anche mediocre, ogni tot tempo.
In tutto questo, la community italiana è in salute?
La community italiana in realtà non esiste. Esisteva quando eravamo di meno e lo sgomitare non necessariamente significava togliere spazio all'altro. Oggi siamo saturi, la lotta è più serrata e spesso si mira a ostacolare il lavoro altrui, piuttosto che migliorare il proprio e contribuire al sistema. A me fa piacere essere associato a un certo gruppo di bartender italiani, perché ci siamo sostenuti e ci spingiamo.

E la community che esiste, o sembra esistere, a volte fa più danni che altro…
La community intesa come guest, agenzie stampa e tutto quello che gravita attorno può essere una trappola. Se qualcuno viene a proporti di fare parte di una maratona di bar a Londra forse c'è un problema, perché dovrebbe essere la community di Londra a invitarti, che magari ammiri e con cui magari hai un rapporto. Se vi portano di punto in bianco, chiedetevi chi ci guadagna, se siete parte di una community o siete un tassello. Io per primo sono stato una pedina, mi sono reso conto di quanto fosse inutile, l'ho capito e ho poi iniziato a declinare.
Si può dire che fai parte della vecchia guardia: è un orgoglio o una fatica?
Ci sto facendo i conti, lo sto capendo fin troppo rapidamente perché inizio ad avere a che fare con gente che non ha i miei stessi punti di riferimento. Se parli con Edoardo Nono, ad esempio, può raccontarti degli ultimi trent'anni di bar: io ho la metà della sua esperienza, ancora meno a livello internazionale, per quanto abbia iniziato a frequentare il bar quando le cose sono cominciate a succedere. I giovani di oggi non hanno vissuto i tempi dell’archeologia, della ricerca quasi manuale e del vero rapporto con colleghi e ospiti che caratterizza il bar vero.
«Senza una missione, chi lavora al bar farebbe meglio a smettere»
Questo si traduce in una mentalità diversa?
Edoardo e io abbiamo una visione epica di questo lavoro, ci ricorderanno per come siamo morti lavorando, non per quello che abbiamo fatto. Il nostro è stato un lavoro di conquista, abbiamo dovuto presidiare una città davvero per anni. Io poi ho cercato una bandiera per cui combattere, che è la giacca bianca, la professionalità che prima non c'era. Senza una missione, chi lavora al bar farebbe meglio a smettere. Per questo sto invecchiando.
La questione della professionalità è cambiata?
Non saprei. Il nostro lavoro è talmente poco professionale che se ce l'ho fatta io, con un po' di volontà si può vincere a qualsiasi età. Non puoi disegnare il concorde dopo tre anni di ingegneria, qui invece con poche mosse giuste puoi scalare classifiche di gradimento. C'è chi lavora per sei mesi da Starbucks, impara un metodo e poi diventa bar manager di cocktail bar di alto livello.
C'è qualcosa che avresti voluto avere tu, delle nuove generazioni?
Ho sempre voluto e dovuto circondarmi di persone più esperte di me. Volevo imparare da loro; oggi si ha la possibilità di stare in mezzo a gente della stessa età che vive le stesse cose con te, si crea quindi un cameratismo che sviluppa il talento come io non ho potuto sfruttare a trent'anni.
All’epoca facevi i catering ai rave party, ora sei ambasciatore delle giacche bianche. Si può fare questo passaggio?
Era un altro momento, si facevano locali stagionali, tavoli di discoteca dove portavo magnum e candelotti. Non voglio dimenticarlo, ma era un periodo in cui si lottava male, tante attitudini che ho adesso, quasi alla sopravvivenza, le ho imparate là. È un ambiente che ti risucchia e ti travolge.
Cosa ti piace meno de L'Antiquario?
È troppo piccolo per fare certe cose, per fornire un servizio di livello ancora superiore. Come paradosso siamo in qualche modo high volume, ricambiamo tavoli in continuazione; fossimo un po' più grandi potremmo essere un po' più informali in modo vincente, magari con anche un po' più di movimento. Purché il movimento sia coerente con la nostra anima.
Lo dici come se altrove non trovassi questa coerenza.
Pare che oggi se durante un guest shift non versi vodka in bocca alla gente, non è una guest e non sei un bar. Io forse lo farei una volta ogni tanto, sono regole della festa che si adattano alle regole del mio bar e viceversa. E questa mia idea mi rende automaticamente escluso da un certo tipo di bar che posso ospitare, perché devo destrutturarli per poterli ospitare, anche se a volte è vincente. Sta di fatto che piuttosto che avere Iain McPherson a L’Antiquario vestito da panda, lo preferirei in smoking a servire solo Martini congelati.
Si vedono anche festival, settimane di guest, eventi messi in piedi da bar che ospitano, organizzano, richiamano.
Alcuni di questi momenti hanno senso, vedi il Maybe Festival, che crea valore; altri lo fanno solo per estrema visibilità, ma senza contenuto. I messaggi sono sempre gli stessi e difficilmente si traducono in concretezza. È una cosa warholiana, inutile.
«Ho visto professionisti eccellenti costretti a mettere una maschera per creare un personaggio. Alla lunga, funzionano male»
C’è un momento più o meno particolare in cui le cose hanno iniziato a cambiare?
Il 2019, o comunque il periodo caratterizzato dall’inizio della pandemia e la sua evoluzione. Da allora mi cadono le braccia perché vedo sempre le stesse facce in giro, l'entusiasmo è finto, è una recitazione continua. Ho visto personalmente professionisti eccellenti costretti a mettere una maschera per creare un personaggio, e alla lunga loro stessi funzionano male.
Considerando la frequenza dei tuoi viaggi e delle tue guest, hai un'esperienza all'estero piuttosto solida: cosa ti impressiona di più di altri mercati e cosa invece ti rende orgoglioso di essere italiano?
A noi manca il rigore. Continuiamo a ripeterci che siamo i migliori, ma siamo degli esempi rari, c'è tutto un mondo di professionalità legate all'ospitalità che noi stiamo acquisendo solo ora. Per dirne una, io non sarei mai all'altezza di lavorare in un luogo con le regole perfette di Monica Berg, perché ha implementato un sistema così rigoroso e al tempo stesso funzionale. Qui non si attuerebbe mai, di quel rigore quasi spaventoso L'Antiquario ha forse il 10%; ci sono posti in cui le eccezioni non esistono, perché esistono manuali da seguire.
Cosa rispondi a chi dice che la vecchia guardia dovrebbe farsi da parte?
Che devono prenderci a calci nel sedere per cacciarci, perché di certo non ci toglieremo da mezzo per fare spazio a loro. Ho visto nel corso dell’anno una guest di Patrick Pistolesi a Firenze: lo guardavo sudare e gli chiedevo cosa ci facesse ancora lì, perché non si levasse dalle scatole, e lui rispondeva “e chi lavora al posto mio?”. Questa attitudine e soprattutto questa voglia ci differenzia ancora dalle giovani leve.
«Serve fare cose che nessuno fa, far girare la testa di 180 gradi a pubblico e colleghi»
E da cosa derivano l’attitudine e la voglia?
Quando iniziammo a girare noi si andava per guest o eventi o anche solo in bar all’estero, ti giravi da un lato e c’era Alex Kratena, dall'altro Simone Caporale, dall'altro ancora Erik Lorincz. Eravamo portati a dover scalare l'Everest, nessuno ci ha regalato spazio: certe cose vanno conquistate, per quanto sia poi il tempo a dover giudicare. Ma per prender il nostro posto dovranno renderci obsoleti, non fare quello che facciamo noi. I giovani oggi rincorrono guest o collaborazioni perché pensano sia quello il modo di fare bar; al contrario, serve fare cose che nessuno fa, far girare la testa di 180 gradi al pubblico e ai colleghi. Il talento oggi è scarso e diluito e stenta a venire fuori; serve sacrificarsi e rischiare di sparire, per fare qualcosa di nuovo e comprendere se la qualità è valida.
A volte però sono anche le circostanze o il momento storico a giocare un ruolo.
Certo. Ci sono bar che hanno aperto troppo presto; Unseen a Milano, ad esempio, poteva essere molto più influente di quanto non sia stato, forse ha spinto troppo e subito. È una sorta di Jimi Hendrix che ha iniziato a suonare come nessun altro suonava, ma non ha avuto tutto il seguito che avrebbe potuto avere.
Tornando a quanto sopra, la vecchia guardia italiana è anche la più solida all'estero: i grandi professionisti oggi stabili altrove torneranno mai in Italia?
Mai. Fa ridere pensarlo, perché quei professionisti lì sono di un altro pianeta, ed è soprattutto il contesto in cui lavorano a favorire il loro talento immenso, non il contrario. Ago Perrone in Italia non potrebbe lavorare da nessuna parte oggi; quando sarà lui a chiedersi quanto vale la pena stare a Londra o rientrare, allora potremo dire di valere qualcosa come nazione e imprinting di ospitalità.
Cos’altro ci manca per poter fare un buon salto di qualità anche in chiave internazionale?
Manca la sana critica, che in Italia è stata sostituita dalle recensioni di TripAdvisor. Servirebbero cinque, sei persone autorevoli e indipendenti; mi sarebbe servito alla grande avere suggerimenti anche duri, scritti da voci importanti, per crescere.
C’è un bivio particolare che riconosci di aver intrapreso, a un certo punto, e che ti ha dato da pensare?
Se mi fossi drogato avrei avuto qualche vantaggio sociale in più.