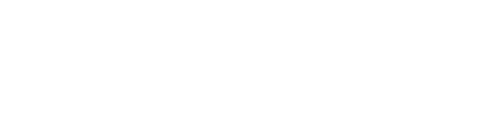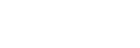Ci sono viaggi che iniziano con una valigia, altri con un frutto. Questo, in Calabria, comincia con entrambi: una tote bag firmata Tassoni e un agrume verde, grande e vanitoso, che non soffre di complessi: è convinto di essere nato prima degli altri, e ha pure ragione. “Il Viaggio del Cedro” non è stato un viaggio stampa, ma una caccia al profumo perduto.
A bordo del pulmino, come moderni Indiana Jones e Lara Croft, c’erano bartender, blogger, creator e Bargiornale tutti con la stessa missione: capire se il cedro Diamante, oltre a finire in bottiglia, potesse anche finire in poesia. Le tappe non erano scritte su un programma, ma sigillate in buste numerate da aprire al momento giusto. Come nei romanzi in cui la trama si svela un capitolo per volta, anche qui la storia si apriva solo se eri disposto ad ascoltarla. O a ricordarti (il mio caso), di avere una busta in mano mentre ammiravi i paesaggi tra Amantea e Santa Maria al Cedro. Dietro ogni busta, una rivelazione.
Un primo attore
La prima lezione l’ha data la Calabria stessa. Non quella da cartolina, ma quella che profuma di rustico: tra un vicolo che sa di pane e una paesana che ti osserva con sguardo indagatorio. Spoiler. Alla fine di questa storia ho riscoperto la Calabria, terra ruvida e gentile, dove il cedro non è un frutto ma un primo attore.
E quando la luce del pomeriggio si è fatta abbagliante, è arrivato lui: Giovanni Canora, coordinatore del Conservatorio di Etnobotanica del Pollino. Sotto un ulivo un uomo che parla di piante come fossero amici d’infanzia. «L’etnobotanica - sottolinea - è la scienza dell’uomo che ascolta la natura. È un sapere orale, antico, fragile. Si tramanda più con le mani, con i ricordi che con le parole. E oggi, in un mondo di sintesi e short content, recuperarla è un atto rivoluzionario».
Canora racconta che la botanica è la materia più interdisciplinare che esista, perché tocca tutto: scienza, arte, religione, cucina. «I pittori del Rinascimento coloravano coi pigmenti naturali. I filosofi scrivevano di piante. E oggi i bartender le usano nei drink. È lo stesso dialogo, solo servito con più ghiaccio». Ride, ma non scherza: dietro ogni cocktail botanico c’è un’etica del gesto. «Usare una pianta senza conoscerla è come cucinare con un ingrediente che non hai mai assaggiato. Le piante vanno maneggiate con cura, con gratitudine»
Tra i filari del cedro
Il giorno dopo, tra i filari del cedro, quella teoria è diventata pelle. I partecipanti hanno raccolto i frutti a mano, in silenzio. Il suono era quello delle foglie che si spezzano piano. Un chitarrista, Andrea Felici, suonava una slide guitar in mezzo agli alberi: la musica si intrecciava ai profumi e il cedro - ruvido, massiccio, quasi ostile - si lasciava prendere come un animale selvatico che, per un attimo, si fida. È lì che alcuni hanno capito per la prima volta che un cocktail inizia ben prima dello shaker. Inizia dal terreno, dalle mani, dal vento che asciuga la buccia. Il cedro Diamante è un agrume che non chiede di piacere: pretende di essere capito. Ha la dolcezza breve e l’amaro lungo. Come certe persone.
Ne sa qualcosa Umberto Oliva, bartender e consulente calabrese, che a questo frutto ha dedicato una filosofia: «Il cedro è un ponte tra l’acido e l’amaro, tra la memoria e l’invenzione. Nella tradizione calabrese si mangiava con il sale grosso: lo spicchio, l’albedo bianca e spessa, il contrasto. Era un gesto primordiale, ma perfettamente bilanciato. In miscelazione è lo stesso: basta estrarre la parte giusta - albedo, scorza, oli - per ottenere equilibrio e identità».
Territorialità liquida
In questo, il viaggio è stato una masterclass di territorialità liquida. Tassoni non ha imposto il proprio racconto: l’ha lasciato emergere dal terreno, dai sorrisi dei coltivatori, dai silenzi dei filari.
Ha ricordato a tutti che la Cedrata, prima di essere una bibita, è un’idea di Italia: quella che unisce un frutto mediterraneo e una bottiglia nata sul Lago di Garda. Un dialogo nord-sud che profuma di cultura e marketing fatto con eleganza: “il lusso di osare”, appunto. Il viaggio si è chiuso con un brunch allestito tra i cedri, arricchito dai tessuti e dalle visioni artistiche dell’artista calabrese Carla Maiolo. Nel diario di bordo, qualcuno ha scritto: “Ho imparato che un profumo è una memoria liquida”. E forse è stato questo, in fondo, il senso del Viaggio del Cedro.
Le botaniche protagoniste
L’etnobotanico Giovanni Canora ha guidato i partecipanti tra lentisco, mirto, origano selvatico e santoreggia montana. Ogni pianta è una storia: il lentisco, resinoso e balsamico, si usa per infusi e liquori; il mirto, sacro agli antichi, per aromi e digestivi; l’origano, delizia delle montagne, è la spina dorsale del Mediterraneo; la santoreggia, detta “erba della felicità”, aggiunge un tocco pepato e afrodisiaco. Tutte, insieme, disegnano il profilo aromatico di una Calabria che parla attraverso i profumi.
Come usare il cedro Diamante in mixology
Il cedro offre molto più del suo succo: l’albedo, spessa e amarognola, può diventare la base per infusioni, oleo-saccharum o cordial. La scorza, ricca di oli essenziali, regala note balsamiche e minerali. L’approccio di Umberto Oliva invita a “riprodurre il gesto del cedro e sale” nel bicchiere: un equilibrio tra sapido, dolce e agrumato che trasforma un ricordo d’infanzia in un’esperienza adulta. Un modo per dire che, a volte, la semplicità è la forma più alta di sofisticazione.